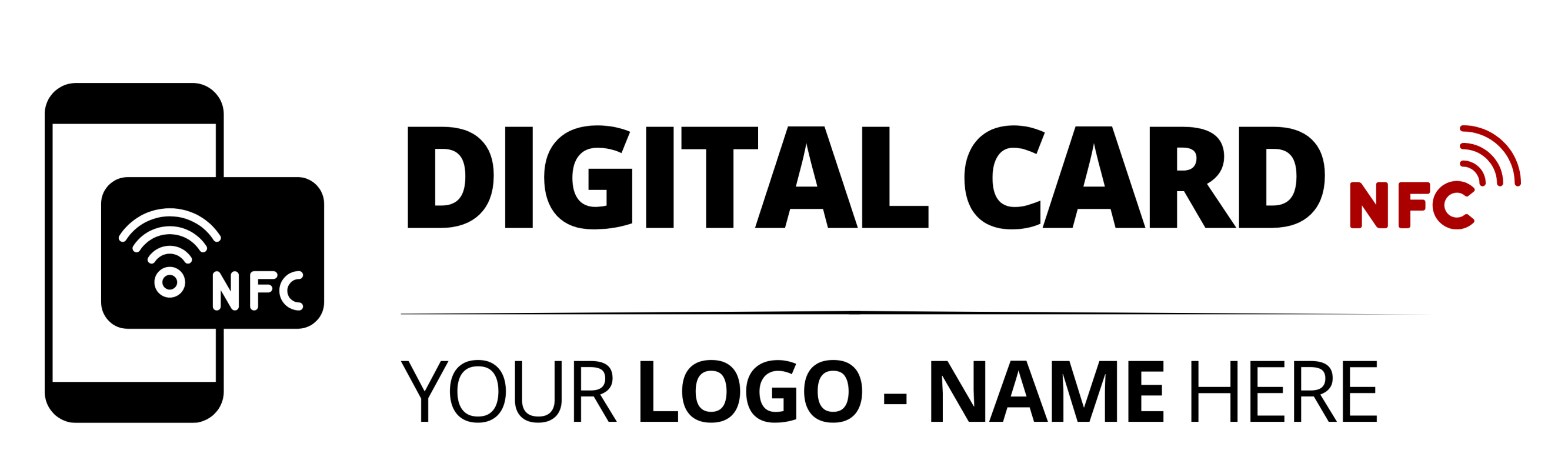Esiste un’Italia irredimibile, un paese carsico eppure sfacciatamente visibile, dove il diritto si scioglie nel privilegio. È quasi l’estate del 1961, una stagione che corre rimpinzata di sogni sulla scia di un miracolo economico che pare eterno, tra il profumo di benzina delle prime utilitarie e il fragore dei cantieri che ridisegnano lo skyline di un Paese finalmente moderno.
Eppure, proprio nel cuore di questa epifania industriale, il calcio italiano provvede alla messinscena di un capolavoro d’ipocrisia, un dramma in tre atti che mescola farsa, arroganza sabauda e orgoglio meneghino, culminando in un nove a uno che ancora oggi lascia ricordi laceranti.
Tutto precipita in un pomeriggio di aprile, allo stadio Comunale di Torino. Juventus contro Inter: sfida per lo scudetto. Non è affatto una semplice partita: è la collisione primordiale tra due interpretazioni del mondo. La folla deborda dai settori, invade il recinto di gioco, siede quasi a ridosso delle linee di gesso. È il parossismo del tifo che annulla le distanze. L’arbitro Gambarotta, sopraffatto da un’insostenibile assenza di ordine, decreta la fine anticipata. Il verdetto di primo grado è un editto di legalità formale: 0-2 a tavolino per l’Inter di Helenio Herrera. Lo scudetto inforca la via della Madonnina, lasciando i bianconeri nella melma di una sconfitta burocratica.
Ma è qui, tra i corridoi bizantini del potere sportivo, che si compie un autentico miracolo all’italiana. Il 3 giugno la CAF decide di compiere un salto mortale degno dei migliori trapezisti del circo Barnum. Il verdetto è ribaltato: la partita va rigiocata. Perché? La motivazione ufficiale si smarrisce in un dedalo di sofismi, ma per interpretare la realtà basta buttare un occhio svelto sull’organigramma dell’organo federale.
A sedere sullo scranno più alto della Federcalcio è Umberto Agnelli, il “Dottore”, l’uomo che incarna il comando. Dettaglio non risibile: è contemporaneamente il presidente della Juventus. Il conflitto d’interessi è vagamente atomico. Al punto che viene naturale chiedersi: chi controlla i controllori?
La reazione del patron interista Angelo Moratti è un ruggito cosparso di dignità ferita, una rivolta aristocratica contro il sopruso. Se il palazzo vuole la farsa, che farsa sia. “Mandiamo i ragazzini”, ringhia al Mago Herrera. La squadra “De Martino” come si chiamava all’epoca. Ovvero, la primavera. E così accade. Il 10 giugno 1961, sul prato del Comunale, non scende la Grande Inter, ma una nidiata di adolescenti smarriti. In mezzo a loro c'è un diciottenne dallo sguardo fiero e dalle gambe ancora sottili, chiamato a raccogliere un’eredità pesantissima: Sandro Mazzola. È un sacrificio rituale, un’immolazione sull’altare della protesta.
Quella che segue è una mattanza travestita da evento sportivo. La Juventus dei titolari, dei giganti, del “Trio Magico”, decide di non avere pietà. C’è qualcosa di ferocemente grottesco nel vedere Omar Sivori, il Cabezón dall’estro maligno e i calzettoni perennemente abbassati, infierire sulla comitiva di imberbi. Lui ne segna sei, con la voracità di un predatore che non sa distinguere tra la caccia e il massacro. La Juventus si fermerà soltanto sul 9-1. Un punteggio iperbolico che resta come una macchia indelebile sulla stoffa di quel campionato.
In questo teatro dell’assurdo, però, splende la luce di un passaggio di testimone. L’unico gol nerazzurro lo firma proprio lui, il giovane Mazzola, su rigore. Un segno del destino tra quelle inevitabili macerie. E mentre la Juve celebra uno scudetto vinto tra mille polemiche, Giampiero Boniperti, l’emblema della signorilità sabauda, compie l'ultimo gesto di un'epoca che svanisce. Si sfila gli scarpini, li consegna al magazziniere e pronuncia il suo addio: «Prendi, a me non servono più». Si ritira nel momento esatto in cui il calcio diventa mescolanza di interessi incrociati. «All’inizio eravamo un po’ imbarazzati – chiarirà – e non avremmo voluto infierire. Ma Sivori inseguiva il Pallone d’oro, che poi avrebbe conquistato, e ci teneva a segnare il più possibile»
«Per me – dirà Mazzola – si aggiunse un problema. Il sabato avrei dovuto sostenere tre esami per completare il quarto anno di ragioneria. A casa mi dissero che lo studio prevaleva sul calcio e che a Torino non ci sarei andato. Supplicai e piansi invano. Per fortuna il preside si commosse e acconsentì a farmi sostenere gli esami di prima mattina. Un’auto della società mi aspettava davanti alla scuola per portarmi a Torino, dove arrivai giusto in tempo per giocare»
Quell’incontro resta lo specchio fedele di un Paese che, pur lanciato verso il futuro, rimane ancorato alle dinamiche del feudo. È la vittoria del potere che si autolegittima, della regola che si adatta al profilo del padrone. Il 9-1 ai ragazzini di Moratti non è solo una statistica da almanacco; è la fotografia nitida, cruda e ironica di un’Italia che preferisce un trionfo discutibile ad una sconfitta degna. È la prova provata che nel nostro Paese, tra il campo e il palazzo, vince quasi sempre il palazzo, specialmente se ha le chiavi di casa di entrambi.