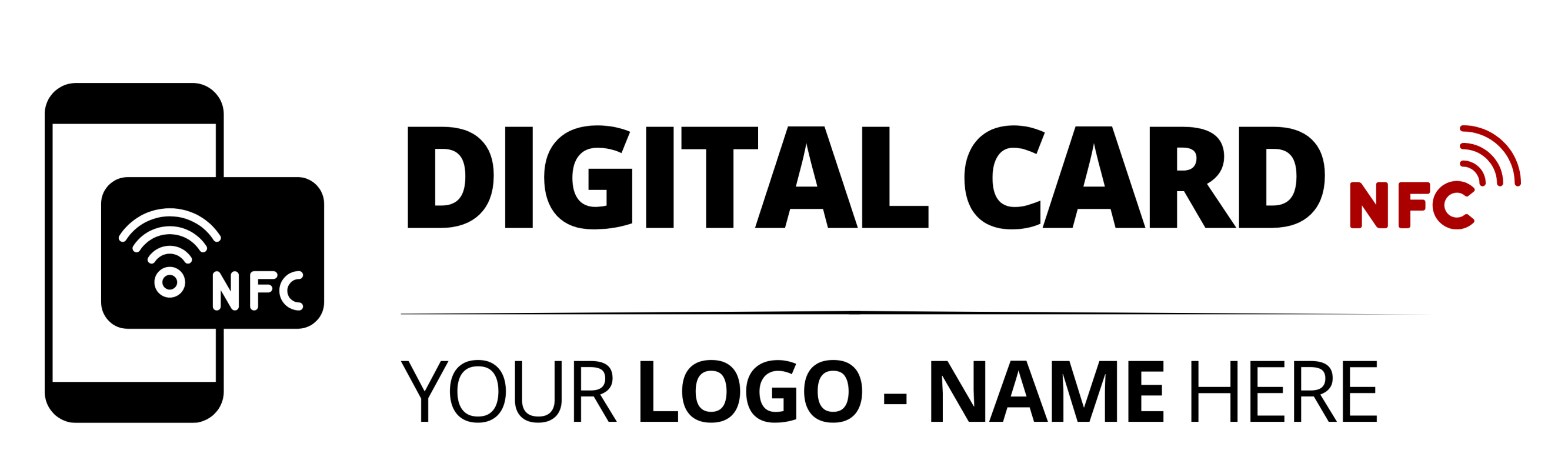Chi più ne ha, più ne vuole, e spesso con fini che vanno oltre al campo. Il mondo dello sport, e in particolare il calcio, sta vivendo l'era delle multiproprietà, ovvero la possibilità, accordata a un singolo o a un gruppo, di possedere una pluralità di partecipazioni azionarie o di diritti reali di proprietà in società calcistiche. Il Galactus di questo settore è il City Football Group (valore stimato di 6,8 miliardi di euro), holding multinazionale britannica attiva nell'intrattenimento sportivo. Fondata nel 2013 su iniziativa dell'Abu Dhabi United Group, con a capo lo sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan, attuale proprietario del Manchester City, il gruppo detiene oggi ben 12 squadre calcistiche sparse in tutto il mondo. Un modello di business che, nel calcio moderno, si sta diffondendo a macchia d'olio. A confermarlo è anche il rapporto UEFA: sono 225 i club coinvolti in strutture multi-societarie in 15 Paesi nel mondo. Di questi, 182 appartengono a campionati europei, con forte influenza statunitense. Nella Serie A la bandiera a stelle e strisce si sta issando sempre più e con la B, sono 12 le società sotto il controllo di investitori o fondi Usa.
Ma perché questa corsa alla multiproprietà? I vantaggi sono numerosi. Sul piano sportivo consente di gestire un ampio parco giocatori: si possono far crescere giovani talenti in campionati adatti alle loro caratteristiche e poi, al momento giusto, trasferirli in altri club del gruppo. Questo riduce i costi di scouting, valorizza i calciatori, consente a realtà minori di poter competere e alle più importanti di assicurarsi futuri campioni. A livello economico e commerciale, la sinergia tra club può rafforzare i brand, aumentare il merchandising e, in generale, far crescere i ricavi. Inoltre, avere più squadre significa diversificare gli investimenti, ammortizzare i rischi ed entrare nelle economie di più Paesi. Tuttavia, i rischi non mancano: conflitti di interesse, squilibrio competitivo, creazione di una sorta di super élite calcistica, mancanza di trasparenza. Ma uno degli aspetti più preoccupanti è la perdita dell'identità del club, che diventa una filiale. L'esempio Red Bull è emblematico: ogni squadra ha un'identità omogenea, spesso cancellando la propria storia.
E poi ci sono le norme. L'articolo 5 del Regolamento UEFA vieta teoricamente a due o più club con lo stesso azionista di partecipare alla stessa competizione europea. Eppure, i casi non sono mancati: Europa League 2018-19, quando si trovarono nello stesso gruppo Red Bull Salisburgo e RB Lipsia, entrambe legate al colosso austriaco; oppure l'ultima edizione della nuova Champions con City e Girona. In quest'edizione, però, il Crystal Palace sarà «retrocesso» in Conference League perchè ha la stessa proprietà del Lione che resta in Europa League in quanto ammessa dal campionato e non dalla Coppa.
L'importante - ed ecco la scappatoia - è che non ci sia «influenza decisiva» da parte del club di punta. Le multiproprietà stanno diventando la normalità in un calcio dove in ogni stagione uno o più club ha bisogno di un salvagente per non abdicare. Un salvagente che porta a una sorta di sudditanza in favore del Faraone - vedi lo Strasburgo col Chelsea (gruppo BlueCo) - ma che allo stesso tempo garantisce la sopravvivenza. La FIFA ha preso di petto la questione, emanando in questi giorni una normativa che impedisce trasferimenti interni tra club appartenenti allo stesso gruppo societario: una mossa pensata anche per incentivare contratti longevi e garantire una maggiore stabilità ai giocatori. Ma si sa: «Fatta la legge, trovato l'inganno». I top club sogghignano, consci di avere le risorse per aggirare la normativa, mentre quelli sottoposti sudano freddo.